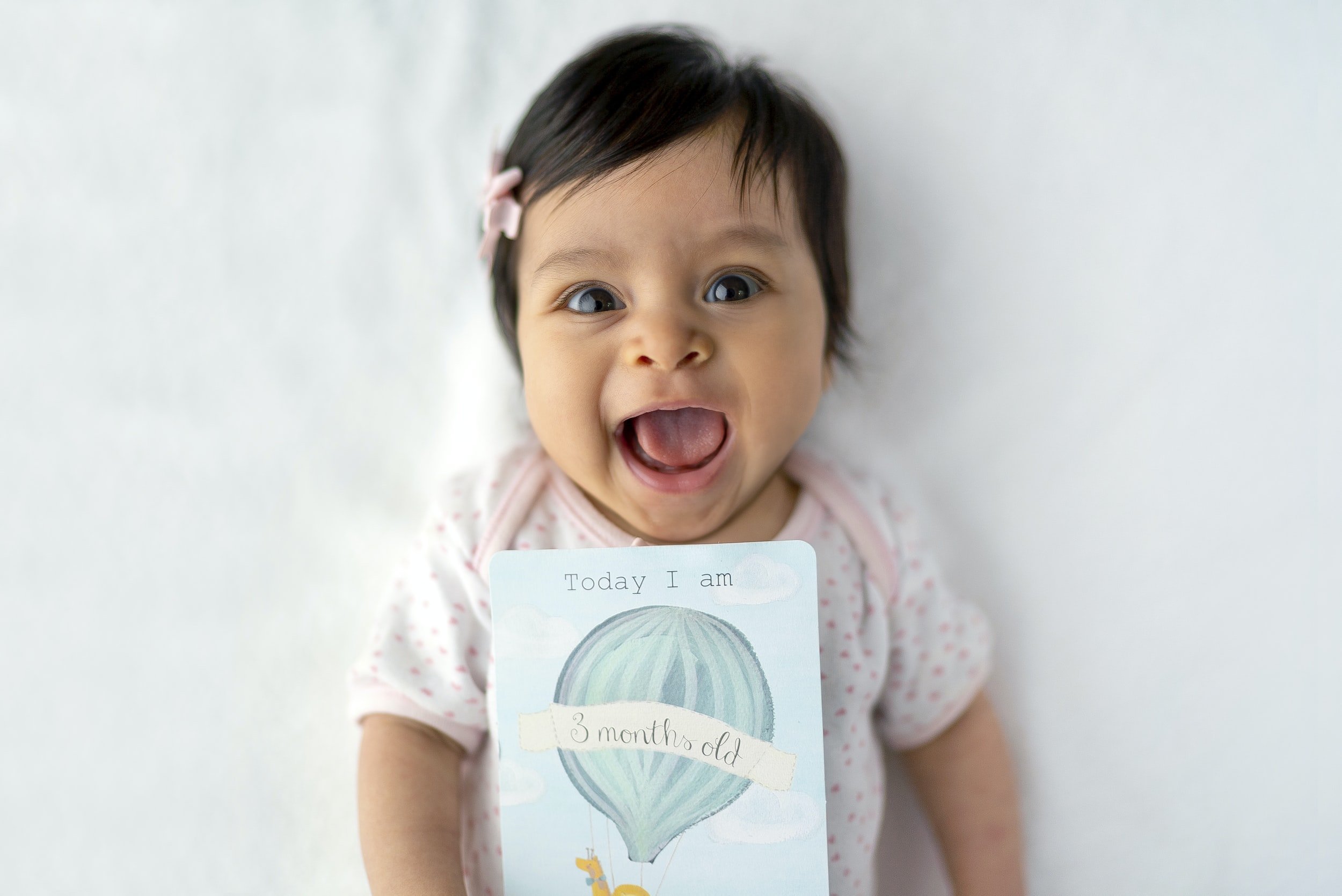La paura
"La paura è probabilmente il più sinistro dei tanti demoni che si annidano nelle società aperte del nostro tempo. Ma sono l’insicurezza del presente e l’incertezza sul futuro a covare e alimentare le nostre paure più tremende e meno sopportabili. Insicurezza e incertezza nascono a loro volta da un senso di impotenza". Bauman
La paura nasce come segnale d’allarme legato alla sopravvivenza pura, all’istinto di conservazione e procreazione rispetto a tutto ciò che è pericoloso: fame, sete, freddo, minacce esterne naturali (buio, altezze, acque profonde, calamità, malattie o incidenti, agorafobia e claustrofobia), animali, vegetali o minerali tossici, uomini.
Appena individua una paura predisposta, il circuito neurale primitivo tende a interpretarla come una questione di vita o di morte, come centomila anni fa, quando una piccola ferita o un rumore nel buio potevano significare la morte. Per questo la forza delle nostre reazioni emotive è spesso sproporzionata alla realtà della situazione.
Queste paure di base portavano con sé altre paure secondarie, quale, in primo luogo, quella dell’abbandono e della separazione (nate nell’infanzia), legate alla dipendenza reciproca dei primi uomini. La paura della morte delle persone care è così forte perché è legata alla paura di perdere familiari e amici che furono quelli che aiutarono i primi uomini a sopravvivere.
La paura dell’abbandono è anche la paura della riprovazione sociale, che poteva portare all’allontanamento dalla tribù e quindi a difficoltà di sopravvivenza: ne è rimasta traccia nella paura di parlare in pubblico: chiunque si esponga agli altri rischia anche la propria sopravvivenza (basti ricordare Gesù Cristo, martiri, Giordano Bruno, Kennedy, Luther King, Gandhi).
Di fronte a una minaccia, il circuito primitivo reagisce secondo due schemi:
• Paura - difesa - panico = fuga (per l’uomo, questa reazione consiste nell’evitare i problemi). Il mediatore chimico attivo nelle prede in maggior misura, è la noradrenalina.
• Paura – difesa - collera = lotta (nell’uomo, significa affrontare i problemi). Il mediatore chimico dei predatori, è l’adrenalina.
Paura, forza e resistenza
• L’accrescimento della forza è dovuto a una combinazione di adrenalina, noradrenalina, dopamina e altri ormoni dello stress.
• Il fegato rilascia glucosio nel circolo sanguigno e ne produce di più.
• Il respiro si fa più profondo e veloce.
• La capacità polmonare aumenta, spingendo più ossigeno in circolo.
• La milza si contrae, emettendo più globuli rossi.
• I vasi sanguigni si dilatano portando più ossigeno ai muscoli e eliminando più scarti.
L’urlo
A queste prime fasi si accompagna normalmente, in tutti gli animali, una reazione automatica al riconoscimento di un pericolo: l’urlo, che ha tre scopi:
1. Come i capelli ritti, ci fa sembrare più minacciosi, facendo (forse) esitare il nemico (effetto sorpresa), e dandoci così il tempo di metterci in salvo o di prepararci alla lotta.
2. Avverte eventuali potenziali soccorritori.
3. Mette altri in guardia dal pericolo.
L’urlo è una valvola di sfogo della paura e del dolore, ma anche di “liberazione” e di gioia. L’energia necessaria per trattenere un emozione così forte è enorme e debilitante.
Se invece la paura è attesa, l’organismo attua la sensibilizzazione, che abbassa la soglia della paura e ci porta a temere cose che prima non ci avrebbero preoccupato, tenendoci all’erta.
Se la paura perdura, entra in gioco l’assuefazione, che alza la soglia della paura. Se non riusciamo ad assuefarci, malattie psicosomatiche da paura ci assaliranno.
Gestione dello stress
E’ importante per l’uomo, che non ha sufficienti sistemi automatici di scarico dello stress, disporre di tecniche cui fare ricorso quando occorre: un bagno caldo, una seduta di yoga, un allenamento sportivo.
La pratica quotidiana, regolare, di un metodo qualsiasi di rilassamento sembra resettare la soglia di innesco dell’amigdala, rendendola meno suscettibile alle provocazioni.
“Non sono le grandi cose che ci spediscono al manicomio, non è la perdita di un amore, ma il laccio della scarpa che si rompe quando abbiamo fretta.” Charles Bukowski
Paure innate
Le paure innate sono incorporate nel sistema nervoso dai geni:
• Il bambino nasce con la paura di cadere (il riflesso di prensione, innato e universale).
• Se un oggetto gli si avvicina velocemente spalanca gli occhi e alza le mani.
• Rumori forti e improvvisi provocano una reazione automatica nell’uomo e in tutti gli animali; non impariamo queste paure, nasciamo con esse.
Paure predisposte
Invece, non nasciamo con quelle seguenti, ma con la tendenza a svilupparle rapidamente in circostanze opportune: ragni, serpenti, altezze, spazi chiusi, tuono, buio, luoghi pubblici o aperti, acqua profonda. Perché i serpenti e non i funghi velenosi?
Tali paure si vincono solo ricostruendole e razionalizzandole, cioè permettendo al trauma o al ricordo di percorrere il cammino dalle profondità del sistema limbico all’area prefrontale, sede della ragione e della coscienza.
Fino a che non ragioneremo sulla nostra paura, questa continuerà ad attivare il circuito primitivo. I soggetti fobici hanno paura di tutti i serpenti, di tutte le altezze, senza distinzioni, perché non hanno accesso al circuito razionale.
L’unica paura condivisa da tutti gli esseri viventi tranne dall’uomo è il fuoco. Si tratta di una paura che l’uomo ha dovuto vincere attraverso lo sviluppo delle aree prefrontali, perché il fuoco, a differenza di serpenti, altezze e acque profonde, era necessario per la sopravvivenza.
Infatti:
• Il fuoco distrugge i batteri della carne.
• Molte piante alimentari sono non commestibili o tossiche se non cotte: fagioli, soia e lenticchie, contengono lectine che danneggiano i globuli rossi e le pareti intestinali.
• La manioca contiene cianuro, distrutto dalla cottura.
• Amidi e proteine dei cereali sono racchiusi in cellule di cellulosa, digeribile solo se cotta.
Nell’homo habilis assistiamo al passaggio dalla visione, all’immaginazione e progettazione: si sviluppa il senso del tempo, dello spazio e delle possibilità.
Poiché gli uomini sono indifesi, rispetto agli altri predatori, e hanno così pochi istinti, sono costretti ad affrontare i pericoli attraverso elaborate previsioni che hanno al centro la consapevolezza del sé.
La consapevolezza, la nostra percezione di un sé unico che fluisce attraverso tempo, spazio e possibilità, è un prodotto del cervello che teme e progetta al tempo stesso, che ci rende paurosi e curiosi.
La paura ci fa agire a senso unico, con reazioni predeterminate.
Il futuro, invece, dipende dalla paura, o dall’amore.
Tutto ciò che facciamo è condizionato dalla paura di qualche cosa, o dall’amore verso qualche cosa.
Ma l’amore è sempre generato dalla paura di restare soli e indifesi:
• Legame materno.
• Amore di coppia.
• Amore per i figli.
• Amore per gli altri.
Se utilizziamo il circuito razionale, allora le nostre paure non sono tutte uguali: possiamo distinguere tra diversi pericoli e agire con raziocinio anziché con l’istinto. Nel momento in cui l’uomo si è trovato a gestire troppe paure, ha dovuto predisporre strumenti di elaborazione razionale che gli permettessero di gestirle.
Un cervello più grande era necessario per la complessa coordinazione di neuroni e muscoli richiesta per scagliare pietre o lance, ma anche per cooperare attraverso il linguaggio, visto che da solo l’uomo non aveva possibilità di sopravvivenza. La cooperazione era stata dettata dalla necessità e dalla paura, ma si reggeva sull’amore.
E’ l’amore che ci ha permesso di evolverci, perché esso presuppone occuparsi della prole, degli altri. Se avessimo continuato a vivere spinti solo dalla paura, non avremmo avuto bisogno di incrementare i rapporti con gli altri, con l’ambiente, limitandoci a rintanarci, e non avremmo avuto bisogno di elaborare un linguaggio parlato complesso, utile solo se si vuole porsi in rapporto con gli altri con amore e positività.
Bambini e paura
Il circuito primitivo della paura comincia a operare immediatamente dalla nascita, mentre i lobi frontali (sede del circuito razionale), solo dopo alcuni anni. I lobi frontali:
• Analizzano il mondo interno e esterno (permettendoci di discriminare tra luoghi bui pericolosi e non).
• Progettano: come risolvere un problema.
• Inibiscono: il circuito primitivo.
Il nostro cervello si è sviluppato talmente in fretta nel processo evolutivo, che non è ancora maturo per la vita umana e razionale se non dopo anni: la gestazione umana, da questo punto di vista, dovrebbe durare 21 mesi e non 9. Ma poiché il bacino della specie umana è disegnato per la postura eretta, l’apertura della pelvi non può essere larga più di tanto, e il piccolo dell’uomo, praticamente un feto, deve nascere un anno prima del dovuto.
Così, nei neonati, i lobi frontali sono talmente immaturi che precoci esperienze di paura e altre emozioni non sono soggette a elaborazione conscia e possono lasciare imprinting subconsci sotto forma di fobie, simpatie o antipatie, manie.
Questo farà sì che il nostro sistema sarà portato a generalizzare, di fronte a una minaccia, non potendo discriminare tra situazioni pericolose e no, perché avrà attivato solo le aree primitive del cervello, e perché la natura ha ideato un sistema di allarme che deve agire immediatamente, senza perdere tempo in classificazioni, specificazioni, elaborazioni razionali.
Vincere la paura
Il circuito primitivo della paura di un claustrofobico vede soltanto uno spazio chiuso, non un ascensore. Ma dato che, per i claustrofobici tutti gli spazi chiusi sono pericolosi, il suo sistema limbico conclude che anche quello lo è, incapace, senza il contributo della corteccia prefrontale, di discriminare tra pericoli reali o meno.
Quindi chi ha subito un trauma non ha bisogno di riviverlo così com’è, ma di farlo analizzare, con l’aiuto di un terapista, dal circuito razionale che inserisca la discriminazione al posto della generalizzazione e della causalità male individuata (superstizione e pregiudizio). Teniamo conto che è molto più facile per il circuito primitivo della paura influire sui lobi frontali che viceversa.
Siamo l’unica specie con un senso del futuro e l’unica che manifesti convinzioni religiose: attraverso la profonda intuizione del fine e del significato della vita, la religione ci fa sentire in grado di dominare la paura della morte e dell’ignoto. Attraverso la diagnosi e la prognosi, la medicina ci illude di avere il controllo sulla nostra salute e quindi sulla morte. In entrambi i casi, per soddisfare le esigenze di un circuito primitivo, occorre utilizzare riti, formule e conoscenze sconosciute, che lavorino a livello inconscio, senza attivare il circuito razionale, affidandosi a una classe di persone depositaria del sapere.
Parole pacate e contatto fisico delicato sono due degli strumenti più sicuri per calmare qualcuno: attenuano l’attività del simpatico nella reazione di lotta o fuga, e aumentano quella del parasimpatico nello schema “fermati e rifletti”: il sistema limbico, l’amigdala in particolare, reagisce intensamente al suono della voce e alla presenza di una persona. Se i neonati (e anche gli adulti) non vengono tenuti tra le braccia e coccolati, il loro sistema limbico comincia a spegnersi, fino alla perdita della capacità di esprimersi e di provare emozioni.
Terapia della paura
Il problema è che il riconoscimento della paura (terapia cognitiva) può non essere sufficiente perché la paura è radicata nel circuito primitivo inaccessibile alla ragione.
Il secondo passo può essere quello della terapia comportamentale, cercando di attivare il lobo frontale di sinistra con pensieri positivi.
Poi c’è il farmaco, che può inibire temporaneamente la reazione di paura, che però ritorna appena si smette.
Ansia
La parola deriva dalla radice greca: “stringere”. E’ la paura del futuro. E’ una sofferenza che proviene direttamente dai lobi frontali, in cui ha sede la nostra consapevolezza del futuro, che ci consentono di analizzare la molteplicità di direzioni possibili che la nostra vita può prendere. Il numero delle cose che amiamo è piccolo in confronto a quello delle cose che temiamo. Amare accresce la nostra paura: ogni amore crea almeno una paura, ma non ogni paura crea amore.
Vivere in eterno
Ogni essere vivente ha in sé un elemento di immortalità: il DNA di ogni essere vivente procede a ritroso, in una linea ininterrotta, per tre milioni e mezzo di anni. Ognuno di noi deriva da una catena ininterrotta di esseri viventi, di madre in figlia, di padre in figlio, in una catena genetica senza soluzione di continuità, attraverso organismi via via più semplici, fino al Big Bang, circa quattro miliardi di anni fa: una parte di noi è stata viva per un quarto del tempo dell’esistenza dell’universo.
Paura e società
Vogliamo sperimentare la paura, in condizioni di sicurezza, per imparare che cosa dobbiamo temere e come comportarci in condizioni di pericolo. La civiltà è una specie di fortezza contro le nostre paure primordiali: al suo interno possiamo perseguire desideri e soddisfare curiosità, senza spendere gran parte delle energie per evitare fame, lesioni e morte, come abbiamo fatto per il primo 95% del tempo dell’esistenza della nostra specie.
Da Machiavelli alla prima bomba atomica, il progresso dell’uomo ha sempre oscillato tra spinte dettate dalla paura o dall’amore.
I recettori
• I recettori del cervello sui quali agisce la morfina (principio attivo dell’oppio), sono stati scoperti solo nel 1972.
• La morfina imita gli oppiacei naturali prodotti dall’organismo (endorfine), isolati nel 1975 e chiamati anche oppioidi.
Come l’alcool, crea dipendenza? Quando una sostanza che dà assuefazione viene assunta frequentemente, il corpo compensa automaticamente l’innaturale aumento dell’oppiaceo, riducendo il numero dei recettori per quella sostanza, la quale genera una reazione di sempre minore intensità (tolleranza) e costringendo, per avere lo stesso effetto, ad aumentarne la quantità da assumere.
Questo significa che la riduzione dei recettori limita la possibilità di legarsi ad essi da parte degli oppiacei naturali che creano una minore dipendenza, ma che sono fondamentali per calmare corpo e cervello.
Esperimenti sui ratti stimolati elettricamente nell’area limbica: a differenza di fame e sete, non esiste un limite di sazietà.
Perché non c’è tolleranza?
Perché gli oppiacei naturali vengono immediatamente inattivati da peptidi nel cervello: ciò vale in tutti casi di secrezione interna di sostanze prodotte dall'organismo (ormoni, neurotrasmettitori, peptidi ecc.) o di assunzione attraverso l’alimentazione di sostanze naturali, non lavorate: l’organismo sa come gestirle.
La stimolazione dei centri del piacere del cervello favorisce la produzione di oppiacei naturali, ma anche neurotrasmettitori come serotonina, dopamina e acetilcolina possono procurare piacere e ridurre la paura e lo stress a seconda del tipo di recettore che viene stimolato (vi sono 14 tipi diversi di recettori solo per la serotonina).
• Gaba inibisce l’azione dell’acido glutammico eccitatore (la normalità è l’eccitazione e il sollievo è la riduzione dell’eccitazione).
• Dopamina: motivazione (da “motus”, movimento, metabolismo, vita), effetto ricercato in molte droghe.
• Noradrenalina: coinvolta nel circuito dell’ansia. Il corpo è in uno stato di allerta ed è pronto alla fuga.
• Serotonina: coinvolta, in caso di carenza, nella depressione.
• Acetilcolina: fondamentale per focalizzare l’attenzione.
La più massiccia concentrazione di recettori per gli oppiacei del cervello è situata nell’amigdala. Ciò può significare che: la realtà fondamentale è la paura e il dolore: ciò che percepiamo come piacere non è una sensazione autonoma, ma temporaneo abbassamento del livello soggettivo di paura e di dolore: quindi…
Il piacere è la percezione del calo di dolore e di paura. Il male è la condizione naturale in cui viviamo: il piacere, il benessere e la gioia sono soltanto eccezioni e anomalie rispetto al corso naturale dell’entropia. (Non è una verità rivelata: è un modo di leggere la realtà che può essere utile ed efficace per migliorare la qualità della nostra vita reale, non di quella illusoria).
Il piacere
Il piacere è il sistema di ripristino dell’omeostasi più semplice per l’organismo: per ridurre l’ipersimpaticotonia prolungata dallo stress, il sistema secerne oppiacei naturali: le endorfine diminuiscono l’attività del simpatico e aumentano quella parasimpatica. Ciò spiega perché bisognerebbe evitare di stimolare artificialmente il sistema neurovegetativo: perché l’organismo reagisce con tolleranza e effetti collaterali.
Tutto ciò spiega perché alcune persone cercano la paura (per dipendenza, cioè maggiore tolleranza alle endorfine) e altre cercano di ridurla con sostanze psicoattive.
La caffeina, per esempio, supera la barriera ematoencefalica, stimolando attenzione e prontezza e produce un lieve senso di euforia e di benessere indirettamente, cioè riducendo la paura di non essere sufficientemente attenti, vigili in una situazione di stress.
Così l’alcool, utilizzato nelle occasioni mondane perché riduce la paura del contatto con estranei, deprimendo la funzione dei lobi frontali attraverso cui sperimentiamo consciamente la paura. Anche i nostri desideri sono legati alla paura e al dolore, non all’amore.
E’ come se fosse più forte lo stimolo doloroso, da cui cerchiamo di sfuggire, rispetto a quello di piacere, che cerchiamo di raggiungere. In effetti, nella maggior parte dei nostri comportamenti prevale la fuga dal dolore piuttosto che la spinta all’amore.
Abbiamo oltre 3 milioni di recettori per il dolore e 280.000 terminazioni sensitive per percepire il dolore, tre volte di più di quelle utili per percepire il piacere.
Si tratta di un sistema di allarme, che ci fornisce informazioni e ci chiede di comprendere il suo significato, o solo di un inconveniente da sopprimere senza farsi domande?
Le terminazioni nervose che trasportano il dolore sono in rapporto di tre a uno rispetto a quelle che trasportano il piacere.
Ci sarà un motivo?
Perfino i nostri desideri sono legati alla paura e al dolore: la fame è legata alla paura primordiale di morire d’inedia; per questo, dopo mangiato, il nostro corpo ci ricompensa con una sensazione di benessere: non serve a ricordarci che mangiare fa bene, ma che non mangiare è pericoloso.
La paura induce a evitare un oggetto o una situazione per via della probabilità che accresca il dolore, mentre il desiderio induce a ricercare un oggetto o una situazione per via della probabilità che riduca paura e dolore. Questa riduzione noi la chiamiamo piacere, benessere, felicità.
Reazioni incomprensibili
Il cervello umano consiste di un insieme complesso di sistemi interagenti: le pulsioni istintive del tronco cerebrale (fame sete, sesso), la paura e altre emozioni preconsce del sistema limbico, e poi pensieri ed emozioni più complesse di entrambi gli emisferi e della coscienza. Essi operano simultaneamente. Per questo avvertiamo spesso impulsi contrastanti.
Per esempio, la risata non è tanto collegata a una esperienza piacevole, quanto al dissolvimento di una paura implicita: è un improvviso calo di tensione che avvia una reazione di rilassamento nel corpo. Quando una paura si dissolve repentinamente, il sistema nervoso parasimpatico (che attiva il “fermati e rifletti”) aumenta la sua attività a scapito del simpatico (lotta o fuga), producendo emozioni positive, come felicità o appagamento.
Siamo una specie tanto paurosa che facciamo di tutto per cercare sollievo alla paura e al dolore: facciamo sport estremi per esorcizzare la paura della morte, cadiamo in depressione per renderci insensibili al mondo esterno, ci teniamo costantemente impegnati (dal lavoro, alla tv, al cellulare), per non riflettere sulle nostre paure.
Siamo praticamente gli unici esseri viventi che cercano di adattarsi a gradire sostanze per le quali abbiamo una avversione naturale: fumo, alcool, caffè, spezie irritanti, sono tra i più popolari alimenti dell’uomo in tutto il mondo. Si tratta di sostanze nervine, che passano la barriera ematoencefalica, attivando un recettore per l’acetilcolina nel sistema limbico che è associato alla riduzione della paura e alla stimolazione del parasimpatico.
Esistono due possibili spiegazioni per il gradimento acquisito di peperoncino o cibi amari:
1) il bruciore causato dal peperoncino e la reazione delle mucose alle sostanze amare possono diventare piacevoli quando ci rendiamo conto che non sono davvero dannose. Si gode del fatto che l’organismo segnala un pericolo, mentre la mente sa che non c’è.
2) Le esperienze dolorose per l’organismo causate da spezie piccanti o sostanze troppo amare, possono indurre il cervello a mitigare il dolore con la secrezione di oppiacei endogeni, che a livelli alti, possono dare piacere.
Paura e novità
Il meccanismo neurale del cervello è costantemente attento a scoprire le novità, perché qualsiasi novità può rappresentare una minaccia. L’evoluzione si basa infatti sul fatto che alcuni uomini hanno vinto la paura delle novità (il fuoco), e dell’ignoto in genere, sfidando i luoghi comuni e il potere costituito. L'evoluzione richiede movimento (metabolismo), e il movimento richiede sofferenza, cioè superamento di una nostra paura.
Ciascuna specie di mammiferi comprende individui che manifestano alti o bassi livelli di paura, con una forte componente genetica. Nell’uomo, pare scientificamente accertato che la selezione naturale abbia preferito i coraggiosi ai paurosi: circa il 15 % delle persone è classificato più pauroso del normale, ma una percentuale doppia è classificata come relativamente non paurosa.
Sembra quindi che la vita vada verso l’amore, che è apertura al nuovo, all’esterno, agli altri, e si evolva grazie al superamento della paura. Ciò vale anche per la terapia: se si vuole risolvere un problema di dolore contingente, la medicina sintomatica è l’ideale. Se si concepisce anche il dolore e la malattia come uno strumento di crescita, occorre anche una terapia energetica.
Se ogni novità può rappresentare una minaccia, è anche vero che ogni vittoria sulla paura comporta una sensazione profonda e duratura di piacere e di benessere attraverso gli ormoni dello stress che…
1) rendono le nostre percezioni più acute, dandoci la sensazione di vivere veramente, e non di lasciarci semplicemente trascinare dalla vita.
2) Rendono i ricordi più vividi e persistenti.
Tutto ciò può portare al piacere della paura: per il circuito primitivo della paura non c’è differenza tra paura reale e paura appositamente cercata: reagisce a entrambe allo stesso modo.
La ricerca del piacere della paura dà assuefazione e dipendenza, fisica e psicologica, che può condurre a irritabilità, cattivo umore e anche depressione. E’ la nostra cultura che vive e ci fa vivere un continuo processo di assuefazione, dipendenza e spasmodica ricerca di eccitazione.
Ricordi dolorosi
Tra il ricordo del massimo dolore fisico e la massima umiliazione, è il secondo il più vivo, cioè il ricordo emotivo doloroso. Il circuito primitivo della paura mantiene vivi i ricordi emozionali in modo che il nostro comportamento presente e futuro ne sia guidato per sopravvivere.
Depressione
Dato che nella maggioranza degli individui il lobo frontale di sinistra è il centro delle percezioni consce di esperienze positive, la depressione può essere scatenata da un livello basso di attività in quel lobo (ma la causa di ciò resta sconosciuta). Più spesso, però, il depresso mostra una attività insolitamente ridotta in entrambi i lobi frontali e anche in molte altre aree cerebrali, oltre che livelli bassi di serotonina e altri neurotrasmettitori nella corteccia prefrontale.
La mente non sperimenta più emotivamente il mondo intorno a sé oppure la propria esistenza.
La riduzione di attività della corteccia prefrontale di sinistra comporta la riduzione della forza di volontà, cioè la capacità cosciente di mutare non soltanto i pensieri, ma anche il comportamento. Alla base della guarigione ci deve essere la volontà di guarire, e questa dipende da:
• La consapevolezza del proprio Io inteso come unità di corpo, mente e spirito.
• La consapevolezza di essere in grado di cambiare.
• La precisa visione di un obiettivo realizzabile a breve.
• Un valido motivo per cui valga la pena vivere.
Stress e sistema immunitario
Scientificamente, paura e stress possono essere padroneggiate solo se riusciamo ad evitare, quando possibile, le situazioni in cui ci sentiamo impotenti e vulnerabili. Se ciò non è possibile, dobbiamo allora sforzarci di mantenere un sincero atteggiamento di ottimismo.
Abbiamo bisogno di sentire di avere il controllo delle situazioni e della nostra vita: tutte le volte che esse dipendono dal comportamento di altri, o dal caso, o da situazioni fuori dal nostro controllo, subentra stress, ansia, paura.
La vita è una ricerca continua di vie di fuga.
La nostra vita è condizionata troppo pesantemente dalle circostanze, dal caso, dalla necessità, dal corredo genetico, dagli altri. Possiamo illuderci di guidarla, ma in realtà quello che possiamo fare è soltanto essere consapevoli che essa consiste nella ricerca della migliore via di fuga tra quelle possibili, all’interno di un ventaglio di direzioni molto limitato.
Perché la paura e lo stress deprimono il sistema immunitario? Perché bloccando il sistema immunitario, come quello digerente, si sottrae energia a distretti non essenziali per convogliarle verso il più immediato bisogno di lotta o fuga.
Questo meccanismo è uno stratagemma della natura per ridurre la popolazione quando diventa troppo numerosa perché l’ambiente possa darle sostentamento.
Atteggiamento mentale
“Molti medici hanno cominciato a rendersi conto che coltivare un atteggiamento ottimistico è altrettanto importante di osservare una dieta sana e fare un moderato esercizio fisico.” Rush W. Dozier Jr.
"I tre pilastri della naturopatia: alimentazione, attività fisica, atteggiamento mentale." Murray e Pizzorno.
Effetto placebo
Oltre che essere dato dal rilascio di endorfine, influenzato da sistema limbico e ipotalamo, che a loro volta influenzano e sono influenzati dal sistema immunitario, l’effetto placebo è benefico perché trasforma la sensazione di impotenza in quella di controllo. Questo è il motivo per cui ci sentiamo meglio solo per il fatto che il medico ha individuato il nome della malattia di cui soffriamo.
Se abbiamo il controllo della situazione, o anche semplicemente ci convinciamo di averlo, solleviamo il sistema nervoso, l’endocrino e l’immunitario dell’enorme lavoro che consiste nel monitorare l’ambiente in cerca di minacce probabili e imminenti.
Gran parte della nostra energia vitale può quindi fluire là dove serve a svolgere le sue funzioni fisiologiche e a riparare danni precedentemente causati dalla nostra paura.
Paura e pregiudizio
Il pregiudizio è il prodotto del circuito primitivo della paura, che, per sua natura, crea stereotipi di individui su basi razziali, etniche, religiose o scientifiche. Il pregiudizio giudica una persona solo come membro di una categoria superficiale anziché come individuo a sé.
L’insicurezza in sé stessi, la paura di entrare in contatto con tutto il proprio essere con il paziente, spiegano il pregiudizio che sta alla base delle classificazioni della medicina tradizionale e l’atteggiamento sbagliato dei terapisti non convenzionali, che incasellano le persone secondo categorie stereotipate (organi della Medicina Tradizionale Cinese , Medicine naturopatiche, costituzioni ayurvediche, tipi umani della psicosintesi, pianeti degli astrologi ecc.).
I 3 circuiti: Primitivo, razionale, conscio.
• Il primitivo è posto al centro del sistema limbico, e serve da allarme. Esamina tutti gli stimoli esterni e interni, generando una continua risposta emotiva preconscia.
• Il razionale, con sede nei lobi frontali, usa il ragionamento corticale avanzato per dividere la realtà in categorie e stabilire i rapporti causa-effetto. Impiega i risultati di quest’analisi insieme all’esperienza di tutta la vita per progettare, prevedere e generare scenari per il presente, il passato e il futuro. Sotto la direzione del conscio, il razionale inibisce o libera il circuito primitivo.
• Il conscio, è il centro della consapevolezza di sé e della capacità di decidere; bilancia le altre componenti della mente, i circuiti primitivo e razionale e i due emisferi cerebrali.
In conclusione, sembra che la vittoria sulla paura non possa essere raggiunta solo con farmaci, cure mediche e psicologiche, ma solo attingendo alle proprie risorse, attivando la forza opposta: l’amore, che richiede tutto noi stessi (contatto fisico, empatia, condivisione). Ciò può avvenire “rieducando” il nostro rapporto con noi stessi e con l’ambiente, alla ricerca del bene, non del male.
Felicità
Caratteristiche delle persone felici:
• Ottimiste.
• Estroverse.
• Dotate di buona autostima (più capaci di vivere in armonia con gli altri, più sane della media).
• controllo di sé.
Come è facile osservare, l'acquisizione e lo sviluppo di queste caratteristiche non dipende dal singolo individuo, ma dal fatto che esso abbia potuto vivere, specialmente nelle prime fasi della vita, in un ambiente sano, amorevole, ricco di stimoli.
Insomma, la felicità dipende più dalla fortuna che da noi, ma questo non significa che da parte nostra non si possa e non si debba fare tutto il possibile per modificare l'ambiente nel quale viviamo in modo da renderlo favorevole alla ricerca della felicità.
Secondo Aristotele, la felicità è collegata alla “entelechia”: quando una cosa realizza la propria naturale inclinazione (interna) e tende al proprio luogo nel cosmo.
Secondo Maslow, chi pensa di poter vivere la vita senza esprimere al massimo le proprie potenzialità, va incontro all’infelicità. La felicità ha come naturale antagonista la paura.